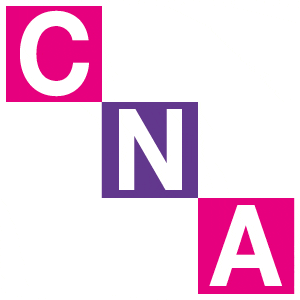Non ci si può accostare a questa opera di Luigi Tazzari senza chiedersi perché abbia scelto il medesimo titolo di un libro di poesie di Eugenio Montale: forse un ricordo degli studi, oppure di luoghi conosciuti e di atmosfere condivise?
Affiora anche il ricordo del modo intimo e sommesso col quale Ugo Mulas tanti decenni fa (era il 1962) aveva interpretato i versi del poeta con un mezzo esclusivamente visivo. Mi raccontava Mulas un anno prima della sua prematura scomparsa, che non aveva voluto realizzare un libro per illustrare i luoghi cantati dal poeta, anche se alcune fotografie sembrerebbero suggerirlo. Aveva invece provato a immaginare con la macchina fotografica i ricordi di Montale, che nei luoghi dell’infanzia non aveva più voluto tornare per non restare deluso dai cambiamenti avvenuti nel paesaggio. Le sue fulminanti fotografie in bianco e nero ci raccontano di questo trascorrere d’impressioni fra poeta e fotografo; impressioni non sicuramente coincidenti e tuttavia collegate dalla sottile e talvolta indecifrabile analogia interpretativa che collega parola e immagine.
Tutte queste idee, però, sono messe irrimediabilmente in crisi appena si scorrono le fotografie di Tazzari, dove ossi di seppia non ne compaiono mai e neppure si rintracciano evocativi paesaggi marini.
Anche se la scelta del titolo conduce proprio in queste direzioni, conoscendo Tazzari neppure per un attimo ho creduto che le sue fotografie potessero in qualche modo ispirarsi alle poesie di Montale. Tuttavia la coincidenza non è assolutamente casuale ma intende operare come uno slogan pubblicitario, che nell’affermare una cosa vuole inviarci un messaggio subliminale differente.
Eccoci dunque impegnati a raccogliere la sfida e a provare a decifrare l’enigma, senza l’ingenuità di volere comprendere appieno il suo pensiero, ma nella consapevolezza che le immagini ci lasciano la possibilità di molteplici interpretazioni.
La prima domanda che ci si deve porre, dunque, è la ragione della scelta di questo titolo.
Il passaggio successivo è verificare se la risposta trova una corrispondenza coerente nelle immagini, per verificare poi, come questo lavoro si inserisca all’interno del linguaggio figurativo dell’autore.
La fotografia di apertura produce immediatamente un disorientamento, ma ci indirizza anche verso la strada giusta per comprendere. Se nelle vecchie edizioni di Montale l’immagine di copertina mostra un rapporto metonimico fra titolo e figura, cioè direttamente corrispondente, qui invece diventa simbolico e ci avverte che nel libro non ci verrà mostrato quanto sembra promettere il titolo, ma qualcosa di ben diverso. Non è un osso di seppia, cioè un avanzo del cefalopodo marino, il soggetto della fotografia, bensì un vecchio guanto di gomma, rifiuto della società dei consumi e simbolo dell’usa e getta reclamizzato decenni or sono da una ditta produttrice di rasoi.
Si chiarisce in tal modo che il discorso fotografico di Tazzari vuole essere una lettura critica della società attuale, del suo spreco e della sua sostanziale “inciviltà”, che la conduce a modificare in peggio l’ambiente. Scopriamo anche che Ossi di seppia è un richiamo ironico a Montale e ai suoi poetici paesaggi marini. Un’ironia amara ma molto efficace come arma di critica. Gli ossi di seppia, quei resti dell’animale marino che da bambini raccoglievamo sulla battigia, mescolati ai gusci di vongole e cozze, ai frammenti di alghe e di legni corrosi dal mare, sono stati sostituiti da sudicerie di ogni tipo volutamente abbandonate dall’uomo e destinate a inquinare irrimediabilmente le nostre coste. Dopo qualche immagine, ci si accorge anche che l’ironia è ferocemente caustica, poiché la sequenza delle fotografie – tutte impaginate allo stesso modo, senza gerarchie formali, con l’oggetto illuminato da una luce radente e inquadrato centralmente – utilizza l’uniformità e la ripetizione informativa per enfatizzare la realtà dei fatti.
Questa modalità linguistica non vuole essere una traduzione italiana delle immagini dei “Nuovi topografi” americani, che mettono in mostra gli aspetti più banali del paesaggio. Le fotografie presentano invece un equilibrio compositivo e cromatico talmente armonioso e studiato, che qualcuna potrebbe essere scambiata per un’opera d’arte informale o materica e tale qualità formale è lo strumento linguistico che consente di accentuare il contrasto fra realtà e sua trasformazione fotografica. La fotografia, dunque, non documenta ma si fa messaggio critico e ci fornisce lo strumento per mettere in moto la nostra capacità di giudizio, con un gioco di rimandi linguistici e significanti ricorrente in molte ricerche fotografiche di Tazzari.
In esse egli sembra seguire un intento narrativo, quasi cronistico talvolta, ma un’attenta osservazione ci fa scoprire una serie di segnali che ne indirizzano il significato verso l’analisi di un mondo sociale complesso e talvolta un poco surreale, dietro il quale si celano comportamenti esistenziali non omologati – né omologabili – al concetto di società del consumo, irreggimentata dietro valori illusori. In tale mondo egli sa cogliere le tracce di resistenza e di autodifesa individuale, come vediamo in Villa Acquadella, dove le baracche sull’acqua non sono soltanto capanne per pescatori dilettanti, ma rifugi dove esplicitare il proprio desiderio di libertà controcorrente. Se quell’ambiente, per le sue caratteristiche, rende abbastanza facile comprendere il messaggio di Tazzari, il suo atteggiamento visivo, mai invadente ma sempre discreto e indiretto, sa fare emergere quanto di alienante caratterizzi altri ambienti e altre attività umane, come rivelano sue precedenti ricerche fotografiche, quali ad esempio Navi e marinai del 2013.
(Massimo Mussini)